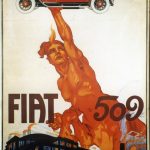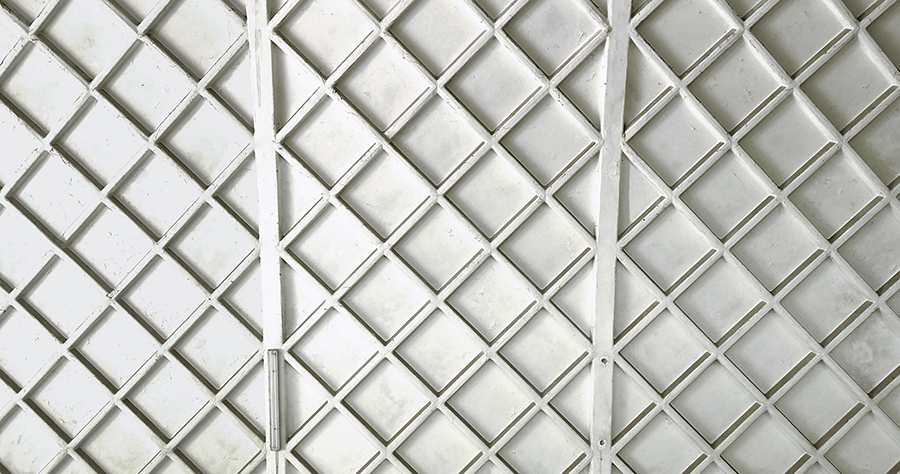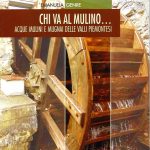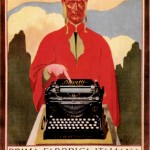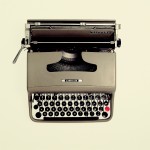Le OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino rinascono come officine della creatività grazie alla riqualificazione da parte della Fondazione CRT avvenuta all’insegna dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale, della memoria storica, dell’accessibilità per tutti.
Le OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino riaprono come luogo della cultura
Mille giorni di cantiere per restituire alla città, dal prossimo 30 settembre, il nuovo cuore pulsante della creatività, della cultura e dello spettacolo proiettato verso il mondo. Cento milioni di euro investiti dalla Fondazione CRT per la rinascita delle OGR – Officine Grandi Riparazioni , la “cattedrale” della storia industriale di Torino. Soluzioni ad alto contenuto tecnologico, sostenibilità ambientale, salvaguardia del valore storico della struttura originale, flessibilità e modularità degli spazi, massima fruibilità durante tutto l’anno, accessibilità for all, sono i principi ispiratori del grande intervento di ristrutturazione e recupero funzionale delle OGR – Officine Grandi Riparazioni, un importante compendio immobiliare dell’Ottocento situato nel cuore di Torino: da ex Officine per la riparazione dei treni a nuove Officine della cultura contemporanea, dell’innovazione e dell’accelerazione d’impresa, con una forte vocazione internazionale.
Clicca qua e scopri tutti gli eventi in programma alle OGR per festeggiare insieme la riapertura di questo grande spazio di archeologia industriale
Le OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino: il sito di archeologia industriale
L’intero complesso di archeologia industriale – comprendente il maestoso edificio a forma di H di circa 20.000 metri quadri di superficie per 16 metri di altezza, le palazzine degli uffici e tutte le aree scoperte – è stato riqualificato da Fondazione CRT che, attraverso un proprio ente strumentale quale la Società Consortile per Azioni OGR-CRT, si è avvalsa di capacità professionali e imprenditoriali del territorio. Le risorse finanziarie messe in campo dalla Fondazione CRT, pari a 100 milioni di euro, hanno quindi fatto da volano per l’economia locale sin dalle prime fasi di progettazione e realizzazione delle opere, avviate il 30 luglio 2014 sotto la guida del Segretario Generale della Fondazione CRT e Direttore Generale di OGR Massimo Lapucci, avvalendosi del Project Manager Arch. Marco Colasanti.
“Le OGR sono la sfida più straordinaria di tutti i 25 anni di storia della Fondazione CRT – spiega il Presidente della Fondazione CRT e delle OGR Giovanni Quaglia –: ci sono state tante complessità, ma anche l’entusiasmo di ridare vita a un luogo bellissimo e unico, un elemento forte della comunità cittadina, aprendolo al mondo. Senza la capacità di visione e l’enorme impegno finanziario della Fondazione, oggi le OGR – Officine Grandi Riparazioni sarebbero un luogo abbandonato privo di futuro, una ferita per la collettività, con problemi per la sicurezza delle persone, la vivibilità, l’ambiente. Così non è stato e, grazie anche all’impegno di tante professionalità e alla collaborazione con le istituzioni, tagliamo il traguardo insieme, perché le OGR, rinate con Fondazione CRT, appartengono davvero a tutti”.
“Da un punto di vista progettuale, le nuove OGR – Officine Grandi Riparazioni sono il risultato di una vision coraggiosa – afferma il Segretario Generale della Fondazione CRT e Direttore Generale delle OGR – Officine Grandi Riparazioni Massimo Lapucci –. Una ristrutturazione di massima avrebbe consentito un utilizzo limitato e parziale delle ex Officine, ma ho pensato bisognasse guardare oltre: fare di questa ‘cattedrale’ della storia industriale di Torino uno dei motori dello sviluppo del territorio”.
“Fondazione CRT – prosegue Lapucci – è da sempre molto impegnata nell’innovazione e nella creazione di valore per la Città, e ritenevo perciò occorresse concentrarsi sull’immaginare il futuro delle OGR – Officine Grandi Riparazioni per poter poi realizzare la riqualificazione più adatta alla nuova vita del vasto complesso immobiliare. Bisognava soprattutto lanciare il cuore oltre l’ostacolo e mettere le OGR in condizione di inserirsi in un contesto internazionale, capace di mantenere l’identità storica di ‘Officina’, ma facendone il luogo della generazione e rigenerazione delle idee. Su queste basi le OGR – Officine Grandi Riparazioni, oltre ad essere il più grande investimento di Fondazione CRT su un unico progetto, sono oggi una delle più rilevanti realtà ispirate ai principi della venture philanthropy in Europa e, coerentemente con la nostra mission, sono sempre attente alle positive ricadute sull’economia del territorio”.
OGR – Officine Grandi Riparazioni a Torino: due nuove piazze nel cuore della città
L’imponente operazione di recupero delle OGR, su un’area complessiva di 35.000 metri quadri, arricchisce e completa la nuova configurazione urbanistica dell’ambito “Spina 2” – l’asse di sviluppo nord-sud della città generato dalla costruzione del Passante ferroviario –, rafforzandone il valore strategico per il territorio. In una zona caratterizzata dalla compresenza, nel raggio di poche centinaia di metri, della stazione ferroviaria dell’Alta velocità di Porta Susa, del Politecnico, dell’Energy Center, di importanti poli privati di ricerca, di istituzioni culturali di eccellenza e del prossimo centro congressi, si inserisce il fondamentale tassello delle nuove OGR – Officine Grandi Riparazioni, quale hub di sperimentazione e produzione di contemporaneità in continua trasformazione e dialogo con soggetti protagonisti dell’arte e dell’innovazione a livello globale.
Il riordino urbanistico di questa parte di città – per la cui attuazione la Fondazione CRT ha affiancato il Comune di Torino – vede anche la creazione ex novo di due piazze pubbliche, vere e proprie agorà connesse funzionalmente alle Officine, ma liberamente fruibili da tutti come luoghi di relax, riflessione, incontro e socializzazione nell’arco della giornata: la Corte Est, affacciata su corso Castelfidardo, con opere d’arte a cielo aperto – la prima installazione pubblica e site-specific sarà “Procession of Reparationists”, realizzata da William Kentridge, tra i massimi esponenti dell’arte contemporanea a livello mondiale – e l’inserimento nella trama della pavimentazione di elementi sia artistici, quali, ad esempio, i profili metallici a simboleggiare le vecchie rotaie ferroviarie, sia di arredo urbano, come le collinette e le panchine ispirate nel design alle locomotive dei treni; la Corte Ovest, su via Borsellino, con un giardino caratterizzato dall’antica torre dell’acqua e da un palco, posto ideale per eventi, spettacoli, esposizioni, ristorazione e aperitivi en plein air.
Proprio in corrispondenza delle due Corti, la campagna preliminare di indagini ambientali ha consentito di individuare la presenza di due vasche interrate contenenti residui del passato industriale delle OGR – Officine Grandi Riparazioni che, per circa un secolo, tra la fine dell’Ottocento e la fine del Novecento, furono uno dei principali poli italiani per la costruzione e la riparazione delle locomotive e dei veicoli ferroviari. Sotto l’alta sorveglianza delle autorità competenti, le due vasche interrate sono state bonificate, è stato redatto e approvato il progetto di messa in sicurezza permanente della totalità delle aree esterne, e sono state realizzate tutte le opere necessarie per rigenerare la qualità dell’ambiente, in modo da offrire ai cittadini nuovi spazi pubblici da vivere liberamente.
Le nuove Officine Grandi Riparazioni: fabbrica delle idee, fabbrica del futuro
L’ipotesi iniziale di sola “messa in sicurezza” della struttura si è evoluta in un’idea più forte e coraggiosa per visione e obiettivi della Fondazione CRT, che ha messo in campo il più grande investimento diretto su un unico progetto, oltre che uno dei maggiori esempi di venture philanthropy oggi in Europa. Il tutto, secondo un modello di filantropia 2.0, in cui un soggetto non profit privato come la Fondazione destina risorse proprie per finalità pubbliche, con un’attenzione alla sostenibilità e all’equilibrio dei conti, attraverso un mix di attività: dalle arti visive e performative alla tecnologia e all’accelerazione d’impresa, dal food fino alla virtual reality.
In dettaglio, le molteplici destinazioni d’uso – le mission delle rinate OGR – Officine Grandi Riparazioni – definite nella Convenzione stipulata nel maggio 2013 con la Città di Torino e aggiornata nel maggio 2017 – fanno delle nuove Officine l’unico esempio di riconversione industriale in Europa con tre “anime” che si integrano tra loro come un ecosistema per lo sviluppo e la crescita del capitale culturale, sociale ed economico del territorio: la ricerca artistica in tutte le sue declinazioni (nelle Officine Nord), la ricerca scientifica, tecnologica e industriale (nelle Officine Sud a partire dal 2018), l’enogastronomia con attività di somministrazione di food & beverage volte a valorizzare, in particolare, le produzioni a filiera corta (nel Transetto).
Dal punto di vista architettonico ed edilizio, i nuovi interventi salvaguardano ovunque la percezione dei grandi volumi e delle grandi altezze, hanno un minimo impatto sulla struttura originale, sono reversibili e riconoscibili nei nuovi materiali, nei colori, nelle scelte di dettaglio.
Anche il tema accessibilità ha guidato la riqualificazione: a questo proposito, per offrire un’ottimale fruizione for all e un servizio di accoglienza in grado di rispondere alle molteplici esigenze dei diversi pubblici, è stato attivato un confronto costruttivo con la Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus.
“La CPD – spiega il Direttore della Consulta Giovanni Ferrero – da quasi trent’anni sul territorio regionale, si occupa di promuovere attività di tutela dei diritti delle persone con disabilità, attivando campagne di sensibilizzazione sulla tematica e realizzando interventi nel rispetto delle pari opportunità per il riconoscimento dei diritti e dei doveri di tutti. Credo che questa collaborazione si presenti quale importante segnale di apertura verso i diversi target che vivranno le esperienze OGR, per offrire servizi e appuntamenti capaci di far sentire tutti protagonisti rispettando le caratteristiche di ognuno”.
Officine Nord: le arti contemporanee
Gli spazi, concepiti per essere polifunzionali su un’area complessiva di circa 9.000 metri quadri (200 metri di lunghezza), ospiteranno, in continua rotazione, mostre, spettacoli, concerti – dalla musica classica a quella elettronica – eventi di teatro, danza e persino esperienze di realtà virtuale immersiva, in una vera e propria digital gallery.
In particolare, le arti visive saranno localizzate nei tre “binari” ovest delle Officine Nord, le arti performative nell’ala est, che mantiene l’antica denominazione di “Sala Fucine”: quest’ultima è dotata di un palco ad altezze variabili (il cui volume crea l’effetto di una “scatola nella scatola”), di tribune per il pubblico mobili e a scomparsa, di una cabina di regia. Il cuore delle Officine Nord è il “Duomo”: l’imponente sala alta ben 19 metri – dove i vagoni dei treni venivano posizionati in verticale per le manutenzioni – sarà destinata a simposi, workshop e conferenze, a sottolineare il cambiamento della missione delle OGR, dalla riparazione dei treni alla riparazione e rigenerazione delle idee.
Alcuni murales sulle pareti, tracce del passato dell’edificio, sono stati conservati per renderli visibili al pubblico, in un gioco di rimandi e contaminazioni tra memoria e contemporaneità.
Officine Sud: l’innovation hub internazionale
Una lunga promenade di circa 200 metri attraverserà le Officine Sud, che mantengono l’immagine storica della navata centrale nella propria integrità, e sono avvolte dalla luce naturale che scende dal tetto e dalle finestre. Nelle due campate laterali – dove l’inserimento del corpo scale metallico ricorda il “respingi vagone” di un tempo –, gli ambienti vetrati per le sale riunioni e i blocchi di uffici open space su due piani, modulari e flessibili per consentire la presenza continuativa fino a 499 persone, testimoniano la rinnovata identità del luogo: hub per la ricerca, “attrattore” e acceleratore delle migliori start up innovative, polo per lo sviluppo progettuale nel settore delle industrie creative, laboratorio dedicato agli Smart Data, centro di sperimentazione funzionale anche alla proposta di contenuti ad hoc per il pubblico delle Officine Nord. Una mission al fianco di importanti partner nazionali e internazionali, tra cui il Politecnico di Torino, Isi Foundation per la ricerca sui Big Data, l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia e il Dipartimento di Stato americano per BEST (Business Exchange and Student Training): il programma bilaterale Italia-USA, di cui le OGR saranno la “casa”, volto a favorire la creazione di start up high-tech nel nostro Paese dopo un periodo di formazione e training di giovani talenti nella Silicon Valley.
Adiacente alla Manica Sud, la cd. Superfetazione, ossia il fabbricato risalente agli anni Cinquanta, ospiterà la biglietteria, il bookstore, la Control Room per il controllo degli apparati di security e del funzionamento degli impianti.
Transetto: le Officine del gusto si chiameranno “Snodo”
Tra le due Officine Nord e Sud, in corrispondenza del Transetto, ci sarà un ampio spazio di circa 2.000 metri quadri con mezzanino dedicato al gusto: si chiamerà simbolicamente Snodo, avrà un forte legame con la filiera enogastronomica piemontese, e sarà aperto dalla prima colazione fino al dopo cena, 7 giorni su 7. Per soddisfare le esigenze di pubblici diversi – visitatori delle OGR – Officine Grandi Riparazioni, studenti, giovani, business community, famiglie ecc. – la taste experience, all’insegna della creatività delle proposte, si declinerà in cinque zone di Snodo: due ristoranti (di cui uno “premium”, con cucina a vista ed esibizioni degli chef che potranno preparare i piatti direttamente davanti ai clienti), un’area lounge a soppalco disponibile anche per eventi dedicati, un cocktail bar sulla Corte Ovest per aperitivi sia d’estate sia d’inverno, uno smart bar con “social table” dalla lunghezza record di 25 metri, pensata come punto di ritrovo, aggregazione e relax per consumare pasti o bevande sfogliando il proprio tablet o pc.
A caratterizzare il Transetto sarà anche l’opera d’arte “Track”, commissionata all’artista venezuelano Arturo Herrera: il grande murale sarà ospitato sulla parete d’accesso alle Officine Nord, diventando una sorta di soglia per l’ingresso nella manica dell’edificio dedicata alle arti. L’opera è stata pensata appositamente per lo spazio, e prende spunto dal passato ferroviario del sito. Il murale sarà composto da un intricato reticolo di linee che possono ricordare un tracciato di binari e che, con il loro diramarsi in varie direzioni, suggeriscono in maniera astratta alcuni dei valori cardine del nuovo spazio: interconnessione, fluidità e dinamismo.
La metamorfosi delle OGR – OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI: la complessità della riqualificazione
Tra salvaguardia dell’identità e della memoria delle OGR – Officine Grandi Riparazioni e l’applicazione delle nuove tecnologie nel rispetto dell’ambiente, la riqualificazione delle OGR – Officine Grandi Riparazioni è stata un’impresa complessa, per i vincoli architettonici e storico-artistici esistenti, il grado di ammaloramento della struttura abbandonata per decenni, l’estensione e le peculiarità del sito caratterizzato da incognite di vario genere e da fattori di inquinamento ambientale e bellico, la molteplicità delle destinazioni d’uso e delle tipologie di utenti, e persino l’emergere in corso d’opera di alcuni elementi non prevedibili, che hanno comportato l’adozione di varianti supplettive e tecniche. Sono stati quindi redatti numerosi progetti in variante sottoposti alla preventiva valutazione della Soprintendenza, e le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni (Comune di Torino, Prefettura, Città Metropolitana, Soprintendenza, Vigili del Fuoco, Asl) hanno emesso complessivamente 27 provvedimenti autorizzativi.
In particolare, le lavorazioni sui tetti ad avvio del cantiere hanno evidenziato problematiche nella tenuta delle capriate e dei relativi puntoni in ferro, delle travi secondarie (arcarecci) a sostegno delle coperture, degli elementi in grado di assorbire le spinte e assicurare la stabilità delle strutture (controventi), della carpenteria lignea, rendendo necessari interventi in quota su 8.000 nodi strutturali. In totale, sono stati impiegati 800.000 kg di acciaio per carpenteria, staffali e bulloni: due volte il peso della Stazione spaziale internazionale (ISS).
Altra sfida decisiva è stata la realizzazione di un edificio caldo, fruibile anche nella stagione invernale, in un “involucro” dell’Ottocento con una volumetria di 260.000 metri cubi, il doppio del grattacielo “Pirellone” di Milano. Oltre all’installazione degli impianti tecnologici di riscaldamento e raffrescamento, sono state migliorate le performance di trasmissione caldo/freddo, con un occhio attento al contenimento del fabbisogno energetico, alla resistenza al vento e alla neve, alla tenuta all’acqua. In dettaglio, tutti i serramenti sono stati cambiati, con l’installazione di 1.200 finestre e porte finestre (per una superficie complessiva di 10.000 metri quadri), tutte a taglio termico, di otto tipologie diverse e di larghezza non omogenea: messe in fila, le nuove finestre raggiungono un’altezza di 6.000 metri, pari a 20 volte la Tour Eiffel. A livello dei tetti sono stati sostituiti 20.000 metri quadri di pannelli delle falde, che hanno richiesto quattro diverse posizioni per le gru di sollevamento. I lavori hanno interessato anche l’intero pavimento, con l’installazione di un impianto a pannelli radianti per 20.000 metri quadri: un’area equivalente a tre campi da calcio.
Le OGR – Officine Grandi Riparazioni sono oggi alimentate dall’acqua di falda, una sorta di “volano termico” che la natura mette a disposizione e che, attraverso l’impiego di pompe di calore per il riscaldamento e il raffrescamento, consente efficienze energetiche maggiori rispetto ai sistemi tradizionali con ridotte emissioni di anidride carbonica (CO2) nel rispetto dell’ambiente.
Tutti i nuovi impianti (elettrici, per l’acqua, l’aria, la fibra ottica) si sviluppano in lunghezza per 115 km, pari alla distanza tra Torino e Aosta: in particolare, sono stati posati 9.000 metri di tubazioni per l’acqua, 4.700 metri di canali per l’aerazione, 55.000 metri di cavi elettrici, 6.500 metri di fibra ottica, 22.000 metri di cavi dati in rame.
L’illuminazione interna “veste” le OGR – Officine Grandi Riparazioni in modo da esaltarne gli ambienti: incassi a terra per la luce d’accento sui pilastri, proiettori per la luce radente sulle capriate metalliche, proiettori “wall washer” per garantire la continuità con la luce del giorno ed elementi a led per una diffusa illuminazione di servizio.
Per garantire la resistenza al fuoco delle OGR secondo la normativa, è stato necessario proteggere tutte le strutture metalliche di sostegno (capriate e colonne di ghisa) con 30.000 kg di vernici intumescenti applicate, nei casi più critici, fino a sette strati successivi. L’intero complesso è dotato di rilevatori di fumi e incendi di diverse tipologie (ottico analogico, lineari a raggi infrarossi e termovelocimetrici, ossia sensibili alle variazioni di temperatura) con interfaccia grafica a mappe delle aree sorvegliate, oltre che, naturalmente, di un impianto di spegnimento a idranti e sprinkler.